Il capitalismo prima di ogni altra cosa è famoso per i ritmi produttivi serrati. Il lavoro, più di ogni altra attività, occupa la maggior parte del tempo delle nostre esistenze. Una soluzione più umana, però, sembrerebbe esserci.
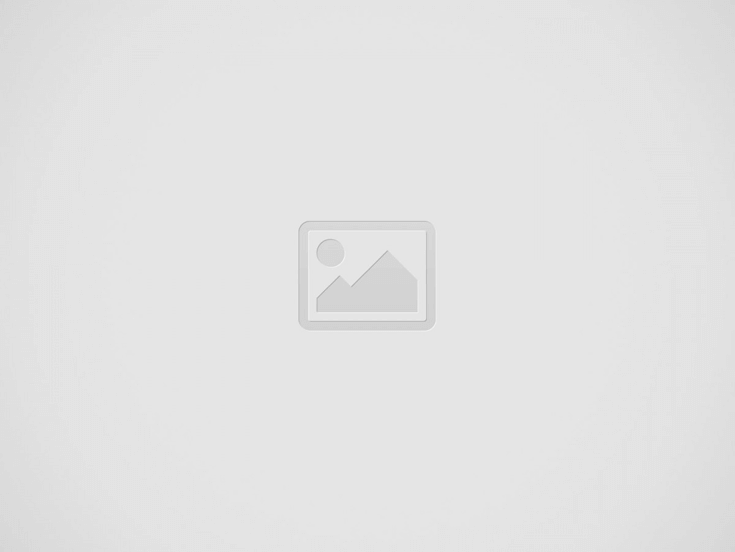

Sul lavoro e le sue strutture portanti la letteratura critica non è mai abbastanza, a testimoniarlo sono i tempi che corrono, dove su 7 giorni almeno 5 sono interessati dal proprio lavoro. La domanda potrebbe essere racchiusa in un breve slogan: il lavoro, coi ritmi di oggi, debilita o nobilita l’uomo? La domanda dai toni vagamente filosofici deve ancora trovare un’adeguata risposta. Possiamo tuttavia menzionare alcuni casi che sicuramente porteranno acqua all’idea per cui non è proprio la migliore delle esistenze possibili quella in cui il 90% del tempo è sottratto alle proprie passioni e inclinazioni naturali, all’esistenza vera e propria scorporata dal profitto.
In ambito internazionale la domanda sta emergendo con forza sempre maggiore così come i casi di malcontento. Con le città sempre più urbanizzate e le metropoli a densità demografiche insostenibili, quello della produzione sembra un imperativo a cui è impossibile sottrarsi, destinale. Non è un caso se proprio di questi tempi sono emersi in ambito scientifico accademico studi sul particolare fenomeno del “burn-out”. Cosa si intende con questa espressione?
Col termine “Burn-out”, letteralmente “bruciarsi”, si intende una condizione di malessere psicologico che colpisce l’uomo contemporaneo costretto ai ritmi e alle pressioni del lavoro moderno. Non siamo più in Tempi moderni di Charlie Chaplin ma la pressione fisica del lavoro in fabbrica è stata trasposta per interno a livello psicologico. Scadenze, mail, lavoro da remoto e altre tecnologie non consentono mai davvero al nostro cervello di staccare la spina e ci rendono inoltre costantemente raggiungibili dal “dovere”.
Le ore di lavoro settimanali variano di paese in paese ma la norma, in Europa, è di circa 40 ore settimanali suddivise in 5 giorni lavorativi per un contratto a tempo pieno. L’Italia, tuttavia, si attesta e supera le 49 ore settimanali lavorative richieste in media. Parliamo di circa l’80% della popolazione interessata da questi ritmi. Ma perché lavoriamo così tanto? vediamo da cosa dipendono queste ore e se un’alternativa è possibile. Quando parliamo di “produttività del lavoro” stiamo parlando della quantità di beni e servizi che un dipendente, un’azienda o un team riesce a produrre in base al tempo e alle risorse utilizzate.
Negli anni la natura della produttività è cambiata assieme all’evoluzione dell’economia a causa dell’incremento della tecnologia. Ciò significa che se durante la seconda rivoluzione industriale per produrre una bicicletta occorrevano in media dalle 20 alle 30 ore, oggi ce la caviamo con 3. Che significa? Significa che la produttività del lavoro è aumentata. A non essere cambiato invece è il procedimento attraverso cui si equilibra il mercato del lavoro. Ad essere centrali in questo senso sono almeno 3 elementi: la produttività, il salario e il processo tecnologico.
L’equilibrio di mercato si ottiene quando il numero di persone disposto a lavorare per una determinata retribuzione è uguale al numero di posti di lavoro disponibili per quella retribuzione. I lavoratori rappresentano la domanda di lavoro mentre le imprese l’offerta. L’equilibrio può tuttavia non raggiungersi a causa dei cosiddetti “shock esogeni”, degli squilibri temporanei che possono condurre alla disoccupazione o alla difficoltà per le imprese nel trovare lavoratori.
Ma accanto alla domanda e all’offerta di lavoro c’è un ultima variabile da considerare: il tempo libero delle persone. L’economista Keynes credeva che grazie al progresso tecnologico che aveva già aumentato ricchezza e produttività durante la prima e la seconda rivoluzione industriale ci sarebbe stata una riduzione della domanda di lavoro. Con macchine più avanzate e migliori processi industriali si sarebbe ottenuto lo stesso livello di produzione, richiesto dalle imprese, in minor tempo. Credeva addirittura che nel 2030 il progresso tecnologico avrebbe condotto a lavorare solo 3 ore al giorno.
Keynes ha sbagliato per due motivi, non ha considerato che le imprese ricercano un profitto sempre maggiore, non si accontentano, cioè, di ottenere lo stesso livello di produzione poiché puntano ad incrementare gli incassi, d’altra parte la richiesta di consumo cresce e continua a crescere. Altro fattore che Keynes non ha considerato è che maggiore produttività vuole maggiore forza lavoro quindi più ore di lavoro da dedicare all’attività. L’aspetto deteriore è che spesso i datori di lavoro preferiscono far lavorare un solo dipendente per più ore che assumerne di più.
Sebbene i dati dell’economista si siano rivelati errati, un’intuizione di fondo da ricavare, c’è: le 8 ore di lavoro settimanale sono insostenibili. Nel 2022 in Italia si sono registrate 1,26 milioni di dimissioni volontarie, il 22 % in più rispetto al 2021. Sono di fatto necessari nuovi modelli di gestione del lavoro che permettano di raggiungere l’equilibrio di mercato senza gravare né sulle imprese né sui lavoratori. In Germania il sindacato IG-Mittal, che rappresenta 2 milioni di metalmeccanici ha ottenuto, nel 2023, un aumento del salario pari all’8,5% assieme a una riduzione dell’orario di lavoro da 35 a 32 ore a settimana.